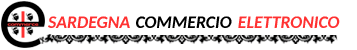Caratterizzata da specificità proprie e tratti fortemente identitari, è stata anche influenzata da tutte le culture e gli stili dei popoli mediterranei con cui è entrata in contatto.
È una pratica diffusa su tutta l’isola fin da tempi più remoti, strettamente connessa alle necessità domestiche e alle risorse derivanti da allevamento e agricoltura, che erano le attività produttive principali fino al secolo scorso.
Il commercio dei tessuti è testimoniato fin dall’età romana e senz’altro l’abbondanza della lana ne ha favorito lo sviluppo, anche se da sola non basta a giustificare una tale ricchezza e ampiezza di produzione, che deve evidentemente qualcosa al talento creativo proprio di questo popolo.
Quest’arte povera ha sempre fatto parte, nei secoli, del bagaglio di attività e di conoscenze di ogni famiglia, esercitata da quasi tutte le donne di ogni ceto sociale e tramandata per secoli di madre in figlia. Il lavoro al telaio era un momento della giornata in cui ci si riposava, si rifletteva e si trasmettevano le storie di famiglia e del luogo.
È ragionevole pensare che ci fosse un telaio in ogni casa, per creare gli oggetti utili alla vita di tutti i giorni. La possibilità di barattarli con altri prodotti si sviluppò quasi naturalmente man mano che la vita sociale andò articolandosi.
In origine i manufatti erano quelli tipici della tessitura popolare. Le donne tessevano per realizzare i propri abiti, le bisacce e il corredo nuziale fatto di coperte, tovaglie, biancheria, tappeti, scendiletto e alcune stoffe decorative. La cassapanca in legno, uno dei pochi mobili di casa, veniva coperta con una striscia di tessuto colorato e finemente decorato.
Al di là della produzione radicata a livello familiare, non mancavano artigiane specializzate che davano vita a iniziative più corporative e imprenditoriali.
A partire dagli anni Settanta furono istituiti dei corsi di formazione e create cooperative. I piccoli telai vennero sostituiti con quelli più grandi e si creò così una rete commerciale di vendita e contatti, adeguando il prodotto ai gusti del tempo.
Da allora si iniziarono a produrre nuovi tipi di manufatti come tende, cuscini, asciugapiatti, presine, tovaglie, asciugamani, in grado di inserirsi armonicamente sia nell’arredamento classico che in quello contemporaneo.
I filati
La principale fibra tessile tradizionale è la lana di pecora, un tempo abbondante come sottoprodotto dei numerosi allevamenti ovini. Agli uomini spettava la tosatura delle greggi, alle donne la cardatura, lavorazione, tintura e tessitura del filo.
Le altre fibre utilizzate sono di origine vegetale: lino, cotone e, fino ai primi del Novecento, canapa. Il lino era prodotto sull’isola fino al secolo scorso, mentre oggi viene per lo più importato; il cotone è raramente prodotto in loco (i tentativi di coltivazione della pianta sono più volte falliti). Casi eccezionali sono rappresentati dalla tessitura della seta e del bisso marino.
Fino al secondo dopoguerra la colorazione dei filati veniva fatta dalle sapienti mani delle stesse tessitrici con piante tintorie autoctone (foglie, fiori, cortecce e radici di arbusti della macchia mediterranea) oppure minerali e terre locali. Poi questa tradizione è scomparsa per far spazio alle moderne tecnologie e ai coloranti all’anilina. Solo in tempi recenti essa è stata ripresa da alcuni laboratori.
La principale fibra tessile tradizionale è la lana di pecora, un tempo abbondante come sottoprodotto dei numerosi allevamenti ovini. Agli uomini spettava la tosatura delle greggi, alle donne la cardatura, lavorazione, tintura e tessitura del filo. Le altre fibre utilizzate sono di origine vegetale: lino, cotone e, fino ai primi del Novecento, canapa. Il lino era prodotto sull’isola fino al secolo scorso, mentre oggi viene per lo più importato; il cotone è raramente prodotto in loco (i tentativi di coltivazione della pianta sono più volte falliti). Casi eccezionali sono rappresentati dalla tessitura della seta e del bisso marino. Fino al secondo dopoguerra la colorazione dei filati veniva fatta dalle sapienti mani delle stesse tessitrici con piante tintorie autoctone (foglie, fiori, cortecce e radici di arbusti della macchia mediterranea) oppure minerali e terre locali. Poi questa tradizione è scomparsa per far spazio alle moderne tecnologie e ai coloranti all’anilina. Solo in tempi recenti essa è stata ripresa da alcuni laboratori.
Fonte: sardegnacultura.it